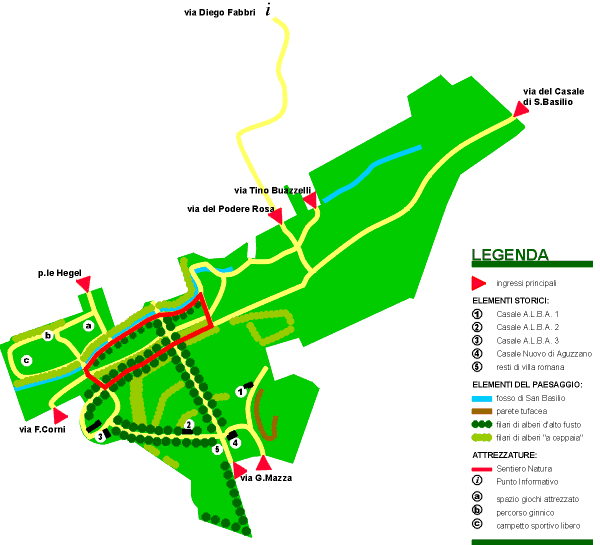PARCO REGIONALE URBANO DI AGUZZANO (ISTITUITO NEL 1989)
CASALE ALBA, CASALI E SERVIZIO AL PARCO. COLLEGAMENTI ECC.
WGS84 latitudine e longitudine pari a 41,56°N e a 12,33°E rispettivamente.
INQUADRAMENTO STORICO E SINTESI DELLE CRITICITÀ
Il Parco è gestito dall'Ente Regionale RomaNatura in collaborazione con il Comune di Roma, proprietario dell’intera area e dei casali storici presenti. È stato istituito nel 1989, su un'area di circa 60 ettari.
La storia antica1
Alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (anno 476) segue, in questa parte della Campagna Romana, un progressivo spopolamento ed un concentramento della proprietà fondiaria nelle mani di poche famiglie nobili, mentre continue donazioni vanno ad accrescere il patrimonio ecclesiastico. Un primo organico tentativo di riorganizzare il territorio del suburbio, ed al tempo stesso assicurare i necessari rifornimento di cibo alla città fu operato da papa Zaccaria (741-752) con l’istituzione delle “domuscultae”. Fondate generalmente sui siti di antiche ville romane, le domuscultae erano dei veri centri di produzione, autosufficienti e autodeterminati, gestiti da funzionari ecclesiastici, con propria milizia e godevano di una particolare protezione del Papa.
Le aree delle tenute di Aguzzano e Rebibbia dovevano far parte della domus culta di Santa Cecilia, fondata dallo stesso Papa Zaccaria ed ubicata al V miglio della Via Tiburtina.
Dal X secolo in poi assistiamo su tutto il territorio suburbano al proliferare di numerose torri di avvistamento, generalmente piantate su ruderi di sepolcri o di ville nei punti di maggior controllo territoriale. È questo il caso delle torri innalzate su ruderi di antiche ville rustiche rinvenute a Casale di San Basilio (a nord-est dell’attuale Parco) o a Casal de’ Pazzi (nell’odierna via Zanardini), edificate in epoca medioevale, utilizzando anche materiale di spoglio, a difesa delle grandi direttrici viarie, la Via Nomentana e la strada di raccordo tra questa e la via Tiburtina (la vecchia Via Casal de’ Pazzi oggi trasformata in parte in via Galbani e Via Zanardini e l’attuale Via Casale di San Basilio). A questi due poli difensivi e di controllo ne furono aggiunti via via altri. La torre a controllo dell’Aniene (detta torre di Guardia e oggi in via di Ripa Mammea angolo via Vittorio Valletta), e quella di Aguzzano (attualmente denominata di Rebibbia), posizionata sulla collina che denominava l’Aniene, lungo l’antica strada che da Casal de’ Pazzi raggiungeva la Tiburtina, oggi parzialmente cancellata e sostituita da via Galbani e viale Kant.
L’impianto delle torri, siano esse di difesa o di segnalazione, assieme a quelle dei casali fortificati, testimonia lo sforzo compiuto dalle famiglie più potenti per riconquistare controllo del territorio. Tra le grandi tenute storiche della campagna romana che si sono mantenute più o meno inalterate fin quasi ai nostri giorni, alcune interessano l’area interna o limitrofa a quello che è oggi il Parco di Aguzzano. I toponimi sono Casal de’ Pazzi, Aguzzano, Aguzzanello, Ponte Nomentano, La Vannina (con il suo casale a precipizio sulla riva destra dell’Aniene nei pressi del Ponte Mammolo) e Rebibbia. La persistenza nel tempo di così marcati segni territoriali, praticamente rimasti immutati per secoli, come appare evidente da un rapido raffronto con gli antichi catasti e la moderna cartografia, molto spesso è indicativa di antichi tracciati stradali che, perduta la loro funzione principale, si sono mantenuti nei secoli come rigidi limiti di proprietà. Il fondo di Aguzzano comprendeva una grande tenuta tra la via Nomentana e la Tiburtina, frazionata attraverso il tempo tra numerosi proprietari. Nel 1630 vengono disegnati per il Catasto Alessandrino: Aguzzano, Aguzzanello e Scortica Bove, tutti e tre di proprietà dell’Ospedale S. Giovanni (SS. Salvatore); i confini erano “il Teverone (Aniene) ed i beni dei Cinquini (Casal de’ Pazzi), quelli degli eredi di 1 Domenico Cecchini e quelli di Sant’Antonio”. Nella seconda metà del ‘700 la tenuta sulla Nomentana e quella sulla Tiburtina vengono riunite con il toponimo di Aguzzano e Aguzzanello alla proprietà del SS. Salvatore. I confini nel 1783 erano: il Teverone (fiume Aniene), Casal de’ Pazzi, Cecchina, Aguzzano o Rebibbia, San Basilio, Grottoni e Pratolungo.
Dai documenti e dalla storia del territorio si evince quindi che con il toponimo di Aguzzano si intendeva una vasta zona tra Nomentana e Tiburtina, frazionata in epoca antica tra diversi proprietari ma all’inizio dell’800 in due sole grandi tenute: quella di Aguzzano Rebibbia e di Aguzzano.
Il frazionamento del territorio con il sistema delle grandi tenute favorisce un tipo di economia rivolta maggiormente all’allevamento brado del bestiame piuttosto che ad uno sfruttamento agricolo. Il progressivo abbandono delle pratiche agricole sarà una delle cause del dilagare della malaria e conseguentemente della fuga delle popolazioni dalla campagna (spopolamento). Solo dopo il 1870, dopo l’Unità d’Italia, saranno presi seri provvedimenti per la riconversione agricola della campagna e per la bonifica della malaria. Nel 1878, dopo lo spostamento a Roma della capitale, venne approvata la legge del progetto di bonifica locale dell'Agro Romano n. 4642. La legge di bonifica prevedeva l’edificazione di casali di nuovo impianto e la costruzione di nuove infrastrutture di servizio che finiranno per intaccare l’integrità che per secoli aveva caratterizzato l’Agro Romano; così come, negli anni venti del ‘900, la realizzazione delle borgate rurali e dei centri di colonizzazione aprirà la strada al successivo frazionamento che sarà alla base del seguente sfruttamento edilizio.
La storia recente
Intorno agli anni venti del ‘900 della tenuta di Aguzzano restano ancora 120 ettari, bonificati dall’ing. Achille Talenti (Roma, 1895 – 1971). Nella memoria degli anziani abitanti delle borgate circostanti, la tenuta viene ricordata come un giardino molto ben curato, con viali alberati e asfaltati, mentre le strade adiacenti erano ancora prevalentemente bianche e sterrate. Ciò che resta oggi sono i 60 ettari del Parco Regionale che occupano per gran parte il fondovalle del Fosso di San Basilio, i tre casali di bonifica e il Casale Nuovo. Sotto il Casale Nuovo di Aguzzano, l’immobile più recente antico all’entrata di Via Gina Mazza, nel 1982 durante dei lavori di scavo sono stati ritrovati resti di una villa con strutture in opera reticolata, alcuni ambienti termali e vani con pavimenti a mosaico risalente probabilmente al I secolo a.C., molto simile ai resti della villa di Podere Rosa, scoperta negli anni ‘90, anch’essa databile in epoca tardo repubblicana ma con rifacimenti protratti fino al IV-V secolo d.C. (Calci, 1998). Due “presidi” della storia antica e della vocazione del territorio, “riconquistato” solo negli anni ’20, dopo un lungo Medioevo in territori insalubri ed in abbandono, con l’impianto della Tenuta Talenti e il costituendo Consorzio Obbligatorio di Bonifica Agraria Cecchina-Aguzzano. Nel 1922 il Consorzio prende il nome di Società A.L.B.A. (Anonima Laziale Bonifiche Agrarie).
Con il Piano Regolatore Generale di Roma del 1962 l’area tra Casal dei Pazzi–Nomentano e Rebibbia subisce importanti interventi di ristrutturazione urbanistica. Il successivo Piano di lottizzazione prevede nuove edificazioni che si protraggono fino ai primi anni ‘70. Con la Delibera n. 2706 del 27/09/1984 il Consiglio Comunale approva il Primo Programma Poliennale di Attuazione del Piano Regolatore (PPA) con i relativi progetti di lottizzazione, compresi quelli della zona di Aguzzano. Questo genera nel territorio e tra le associazioni ambientaliste (con Italia Nostra come capofila) la volontà di opporsi alla colata di cemento che avrebbe invaso l’ultimo lembo di campagna romana all’interno del Grande Raccordo Anulare, nella periferia nord orientale della città. Vengono presentate numerose opposizioni, frutto di un lungo e difficile lavoro tecnico, urbanistico e politico portato avanti dal gruppo di cittadini intenzionati a promuovere la creazione di un grande parco al centro di quartieri preesistenti privi di aree di verde pubblico e densamente edificati e di quelli in via di costruzione. Il Secondo PPA conferma ancora una volta la edificabilità del comprensorio di Aguzzano ed è solo con l’intervento della Regione Lazio (sempre sollecitata dalla mobilitazione popolare e da un puntuale lavoro politico) che inizia a delinearsi la non conformità del Piano di lottizzazione alle previsioni del P.R.G. relativamente alla viabilità principale. Con la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 18- 19/3/1986 finalmente il territorio di Aguzzano viene escluso dalle aree immediatamente edificabili previste dal Secondo PPA, una sorta di “sospensiva” per avviare una ulteriore verifica da parte degli uffici del Comune insieme a quelli della Regione (Leone e Patriarca, 1992).
E’ bastato questo “time out” per immaginare, ideare, inventare ed istituire il “Parco Regionale Urbano di Aguzzano”.
“Aguzzano è risultato vincente in virtù della straordinaria ricchezza della sua povertà” diceva Loredana Minelli Scheda, personalità eminente del cosiddetto “gruppo trainante”, piccolo nucleo di cittadini che si era messo in gioco, rivendicando, chiedendo qualità, progettando, coinvolgendo non solo cittadini ma anche personalità della cultura e dell’arte, fino a giungere all’approvazione della legge regionale 8/8/1989, n. 55 “Istituzione del parco regionale urbano di Aguzzano. La legge istitutiva del parco è stato il vero caposaldo che ha permesso di salvare questi pochi ettari di agro romano ancora integro e che ha saputo rimuovere l’insormontabile problema della destinazione urbanistico/edilizia del Piano Regolatore del 1962. I due presupposti della mobilitazione per il parco furono:
- smettere di costruire case “contenitori”, ma progettare una “città per i cittadini”;
- affermare l’importanza dello scambio tra centro e periferia della città.
L’importanza crescente del rapporto centro-periferia che negli anni ha caratterizzato il dibattito culturale urbanistico e la scoperta del fondamentale ruolo ricoperto dai parchi urbani dimostra che la base su cui si era impostata la rivendicazione per Aguzzano era semplicemente ….. giusta!
SECONDO PEZZO - Pezzo da aggiungere e correggere
Grande promotore del complesso percorso della legge presso il Consiglio Regionale del Lazio fu l’allora consigliere del Partito Comunista Italiano Rinaldo Scheda che, con grande abilità e passione seppe portare il suo partito, che non aveva certo posizioni ambientaliste, ad un voto positivo sull’istituzione di un parco regionale di così modeste proporzioni. Anzi, il coinvolgimento della Cooperativa Nova, costruttori legati al PCI, tra il consorzio di costruttori del comprensorio di Aguzzano gli ha dato spunto per porre all’interno del suo partito la “questione morale” sulle decisioni urbanistiche che si stavano concretizzando a quei tempi su Roma. Ma già nel 1986 Scheda, allora segretario confederale della Cgil, sempre molto sensibile agli stati d’animo della base, aveva capito che la questione ambientale cominciava a prendere forma nella società, ed aveva chiesto ed ottenuto che la festa del tesseramento della Cgil si facesse sui prati di Aguzzano (13 – 14 giugno 1986). Alla festa era stato invitato anche l’assessore all’urbanistica del Comune di Roma Antonio Pala che, in quell’occasione dichiarò: “Per questa estate non c’è pericolo di ruspe su Aguzzano….”.
Ma già dal 1984 per la città, dove “tuonava” alta la voce di Antonio Cederna, la “questione ambientale” cominciava a percorrere rapida le vie della consapevolezza. Su La Repubblica di domenica 25 novembre del 1984 Cederna scrive un articolo di spalla sulla pagina nazionale: “Il cemento avanza sul verde di Rebibbia”. In “località Aguzzano” c’è un’area libera di cemento da salvare, e pesante è la denuncia: “Non si può continuare a riempire, a saturare ciecamente ogni vuoto, e fare di Roma un ininterrotto tavoliere di cemento”. A questo articolo ne seguirono moltissimi altri di tanta stampa che allora aveva un ruolo di informazione importante ed influente.
Una volta istituito il parco l’azione delle cittadine e dei cittadini per la tutela del nuovo parco non si è certo arrestata, anzi il piccolo gruppo iniziale si ampliò. Nel marzo 2005 nasce La Rete per Aguzzano costituita da diverse realtà: l’associazione Casale di Podere Rosa, l’associazione culturale Papillon-Rebibbia, l’associazione culturale Rebibbia Insieme-Gente di Aguzzano, l’associazione Insieme per l'Aniene, l’associazione sportiva "... che l'erba cresce", l’ATI LIPU- Casale Podere Rosa, il Centro di Cultura Ecologica/Archivio Ambientalista-Casale Alba3-Le Vaccherie e la Sezione di Roma di Italia Nostra. All’interno di questa partecipazione popolare scaturiscono idee, maturano competenze, si scrivono delle linee guida per l’utilizzo dei casali, prendono corpo proposte concrete che però non trovano alcun interlocutore istituzionale disposto ad ascoltarle. Cresce all’interno di questo gruppo l’opposizione per le decisioni prese dal Comune di Roma a fine 2007 sul protocollo d’intesa che definisce la gestione dei casali di Aguzzano (appena acquisiti con le procedure della compensazione) che vuole assegnare alla Maraton Club il Casale Nuovo di Aguzzano, per farne la “Casa del podista” e alla cooperativa sociale Artemisia il casale Alba 1. Nel novembre del 2007 la Rete prende posizione con un forte comunicato stampa dove si dichiara di non accettare il concetto di “valorizzazione” espresso dall’allora assessore al patrimonio del Comune di Roma Claudio Minelli, nei confronti del parco e dei suoi casali. Comunque solo l’accordo con la cooperativa di manutenzione del verde Artemisia va in porto, accordo che prevede, in cambio della cessione del casale la manutenzione di parte dell’area verde del parco. Dopo alcuni anni e dopo aver operato una cattiva ristrutturazione dell’immobile denominato Alba 1, che per vent’anni era stata chiesa del quartiere di Rebibbia (infatti il suo nome era il Casale del Padre Nostro) Artemisia lascia in un grave stato la struttura (peggio di come l’aveva ricevuta) ed abbandona la partita. Nel frattempo il Casale Nuovo di Aguzzano, già in grave stato strutturale, viene ripetutamente sgombrato e rioccupato da famiglie di senza tetto. Stato in cui versa ancor oggi. Mentre il Centro di cultura ecologica nella Biblioteca Fabrizio Giovanale, aperto nell’ex Vaccheria opportunamente restaurate, viene concesso all’APS Lipu-Casale di Podere Rosa attraverso un bando, e funziona anche come “casa del parco”. Vi si svolgono importanti incontri tra cui quelli dell’Agenda 21 del Municipio, con l’Università della Sapienza impegnata nel percorso con la compianta professoressa Silvia Macchi. Il centro di cultura ecologica e la biblioteca lentamente diventano punto di riferimento, soprattutto per giovani studenti. Terminano anche i lavori di ristrutturazione del casale detto Alba 2, previsti della “compensazione”, ed il casale è pronto ad essere utilizzato. L’idea viene nel 2011 alla Regione Lazio. Utilizzare il piccolo casale per fare una residenza protetta per detenute con bambini di età inferiore ai tre anni. La struttura è quella dell’ICAM (istituto a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a tre anni) che dipenderebbe dal vicino carcere femminile di Rebibbia. Il Ministero di Grazia e Giustizia presenta un progetto che altro non è che trasformare il piccolo casale in un “fortino”, in altre parole in un “mini carcere”. Si chiede anche una variante al Piano d’Assetto (che ha valore di piano regolatore), elaborato dal Comune di Roma ed approvato dalla Regione Lazio nel 1991. Contro questa proposta si mobilita anche Italia Nostra che diffonde un appello a non modificare l’impianto del piano d’assetto (in data 12 giugno 2012) giudicandolo come l’ennesimo attacco all’Agro Romano. Italia Nostra fa anche puntuali osservazioni alla variante. Nel frattempo sul territorio si raccolgono 3000 firme contro la variante al Piano d’Assetto e al proposta del “mini carcere”. La Rete si estende e diviene Coordinamento per la tutela del Parco di Aguzzano, dove alle storiche associazioni della Rete si uniscono numerosi cittadini, oltre che l’associazione della Brigate Verdi e i cittadini del CO.CO.QUI. (Coordinamento Comitati Quinto), il Comitato di Quartiere Rebibbia, il Comitato Promotore dei Quartieri Aguzzano-Casal de' Pazzi e il Comitato Salviamo Rousseau. Dai tempi dell’istituzione della legge del parco non si era mai vista tanta partecipazione. Il 2012 è l’anno della Festa dei Casali. Il primo aprile, il primo maggio, il 21 luglio sui prati di Aguzzano si svolgono manifestazioni ludiche in omaggio al parco e ai suoi casali. In dicembre, in nome del Coordinamento parte l’occupazione del casale Alba 2. Alcune associazioni si dissociano e si allontanano, ma l’esperienza prosegue, ed è ancora in atto con proposte e attività socio-culturali per il quartiere e la città. La proposta di variante sul casale Alba 2 nel frattempo decade, in quanto il Ministero di Grazia e Giustizia non accetta le limitazioni imposte al progetto ICAM viste le prescrizioni di Roma Natura, l’Ente di gestione preposto dalla legge alla tutela del parco. Nel settembre 2018 arriva un altro attacco all’unitarietà del parco ed alla sua legge di istitutiva. Questa volta dal Comune di Roma e, in particolar modo dal Municipio IV arriva uno schema di deliberazione della Giunta municipale che chiede di dare in concessione il casale detto Alba 1 mediante bando a “favore di associazioni, enti o società con finalità didattiche e sociali inerenti al tema del food” (delibera ad iniziativa della Giunta del IV Municipio n°21 del 12/12/2018). La vaghezza nel corpo stesso della delibera, la disponibilità del privato a dover restaurare l’immobile con opere a scomputo della locazione, l’aperta violazione del Piano d’Assetto e alle previsioni sulle attività da progettare e svolgere nei casali, ha scatenato l’insurrezione popolare. Da più parti ci si mobilità per ridare senso all’istituzione di queste aree naturali protette che, all’interno del Comune di Roma hanno una legge di tutela regionale, che preservano nel loro interno valori ambientali e di biodiversità che non dovrebbero essere intralciati da progetti non compatibili ma, anzi gestiti con regole e interventi mirati. La presenza in Aguzzano di strutture edilizie come i casali storici non può e non deve far pensare che il modello sia quello dello sfruttamento e valorizzazione con obiettivi esclusivamente economici. La grande mobilitazione, le numerose lettere aperte, le memorie i documenti presentati e consegnati alla politica del IV Municipio, l’intervento della Regione Lazio e dell’ente Roma Natura, hanno fermato l’operazione “food” nel piccolo casale di Aguzzano. Ma a quando la prossima proposta? Cosa riserva il futuro alla complessa e gloriosa storia di questo parco?
_________________
1 Fonte: “Il territorio del parco: aspetti storici” a cura di Antonio Mucci e Paola Rossi, in Leone, A.M., Patriarca, R, 1992. Il Parco Regionale di Aguzzano. Quaderni dell’ambiente n. 2. Comune di Roma – Ufficio Tutela Ambiente.
Queste sono le note all’interno del testo
1 Da: Roma Oltre le Mura – Lineamenti storico topografici del territorio della V Circoscrizione – a cura di Carmelo Calci – 1998
1 Da: “Come eravamo…” Ponte Mammolo memorie di un pioniere - di Pietro Franci – 2008
1 Da: Quaderni dell’Ambiente 2 – Il Parco Regionale di Aguzzano – Comune di Roma Ufficio Tutela Ambiente - 1992
STATUS E ITER NORMATIVO
DOCUMENTI DELLE ASSOCIAZIONI
FOTO E PLANIMETRIE
POSIZIONE D'ITALIA NOSTRA
................................................
................................................
COMUNICATI STAMPA
Per contatti
+ 39 06 8414012
roma@italianostra.org